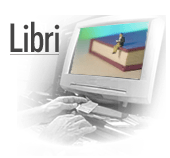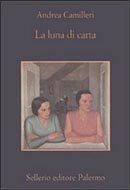La vampa d'agosto La vampa d'agosto
 La luna di carta La luna di carta
 Privo di titolo Privo di titolo
 La prima indagine di Montalbano La prima indagine di Montalbano
 La presa di Macallè La presa di Macallè
 Il giro di boa Il giro di boa
 Le inchieste del commissario Collura Le inchieste del commissario Collura
 Camilleri legge Montalbano Camilleri legge Montalbano
 La linea della palma La linea della palma
 La paura di Montalbano La paura di Montalbano
 Il ladro di merendine in Cd-rom Il ladro di merendine in Cd-rom
 Il re di Girgenti Il re di Girgenti
 L'odore della notte L'odore della notte
 La scomparsa di Patò La scomparsa di Patò
 La testa ci fa dire La testa ci fa dire
 La gita a Tindari La gita a Tindari
 Gli arancini di Montalbano Gli arancini di Montalbano
 La mossa del cavallo La mossa del cavallo
 La concessione del telefono La concessione del telefono
Nell’ultima
fatica di Camilleri, La luna
di carta, il più famoso commissario letterario d’Italia si trova stretto
nella morsa di due belle “fìmmine”, entrambe insidiose sebbene caratterialmente
agli antipodi, due donne che finiranno per mettere a dura prova la capacità di
Montalbano di resistere alle tentazioni. D’altra parte sono proprio loro a
distogliere il protagonista dallo scenario di malinconia esistenziale che lo
avvolge all’inizio del romanzo,
in cui lo scopriamo da qualche tempo assillato da un “mezzo” pensiero ricorrente,
purtroppo relativo all’inesorabile avvicinamento al giorno della propria morte.
E poi arriva l’inevitabile “ammazzatina” dalle modalità improprie che
assorbirà, come sempre, le attenzioni (conscie e non) del nostro eroe
liberandolo dall’ossessione del memento mori: la vittima stavolta
risponde al nome di Angelo Pardo, un informatore medico-scientifico, trovato
morto nel suo appartamento in una posa oscena peraltro discordante con lo stato
del cadavere, che esclude la possibilità di rapporti sessuali prima
dell’assassinio. L’impagabile commissario di Vigàta
inizia così ad indagare alternandosi tra le due donne più vicine alla vittima –
la sorella nubile e l’amante sposata –, trovandosi presto stretto in un’intricatissima
rete di illusioni fuorvianti: prima conosce la sorella, volutamente dismessa,
morbosamente gelosa del fratello, dotata di temperamento chiuso ed introverso,
ma divorata da ardori segreti; quindi passa all’amante, estroversa e sensuale,
franca fin quasi all’imbarazzo, con un passato dimenticato da ex tossica
strappata alla strada da un marito anziano e voyeur. Le due vanno
sgambettandosi a vicenda, irretiscono il buon commissario in un recinto di
mezze verità, trappole emotive ed esche scenografiche. E Montalbano vacilla
davanti alla luna
di carta che vede prender forma davanti ai suoi occhi: “Quann’era
picciliddro, una volta so patre, per babbiarlo, gli aveva contato che la luna
‘n cielu era fatta di carta. E lui, che aviva sempre fiducia in quello che il
padre gli diciva, ci aviva criduto. E ora maturo, sperto, uomo di ciriveddro e
d’intuito, aviva nuovamente criduto come un picciliddro a dù fìmmine […], che
gli avevano contato che la luna era fatta di carta”. La solita ‘esplosione’
intuitiva del protagonista gli consente di stringere una verità utile soltanto
a completare lo scenario di tragica passione che ha innescato l’omicidio.
Secondo consuetudine, anche ne La luna di carta non mancano allusioni
esplicite alla situazione politica attuale: la mordace digressione di
Montalbano su “Mani Pulite”, dieci anni dopo, esprime tutta l’amarezza di Andrea Camilleri
riguardo alla classe politica di oggi, corrotta ed inquinata da vizi
inconfessabili. Insieme al caratteristico impasto linguistico siculo-italiano
che da sempre caratterizza l’opera camilleriana, in questo ennesimo capitolo
della saga di Moltalbano sono le irresistibili idiosincrasie del commissario
nazionale che continuano a funzionare, rendendo unico ed amato in tutto il
mondo un personaggio che, nonostante tutto, continua a credere nella giustizia
e – perché no? – anche nell’amore. In attesa di ulteriori sviluppi, il caso
Montalbano resta aperto...
Andrea Camilleri, La luna di carta, Palermo, Sellerio, 2005, pp. 267
Voto
8
|
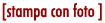
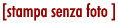
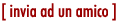 |
|