L’aria fritta, i sofismi arzigogolati, i pensieri contorti, i filosofeggiamenti non sempre vengono al pettine. Anzi, molto spesso, causa l’ignoranza diffusa ed il mestiere di alcuni, prendono campo e storia, personaggi di dubbio fascino, di ancora meno cultura, capaci soltanto a starnazzare in salotti, a parlarsi addosso. Oggi, come allora, all’epoca di Aristofane. Ci vuole allora un tocco
di sana ironia per smascherare il trucco. Niente è cambiato, potremmo dire. “Le
nuvole”, del visionario Antonio
Latella (ancora 10, timburtoniano), sono aria che gorgoglia e non lascia segno ma occupa volume e spazio altrimenti dedicato ad altro, rubando anche l’ascolto, riempiendo le orecchie di quel nulla che imbottiglia e non lascia libero il pensiero, di formarsi liberamente,
di andare e girovagare, di cercare ed assorbire. Una lobby, un clan chiuso, un circolo vizioso raffigurato con un teatrino mignon, piccolo,
piccolo, un “Pensatoio”, una setta, alla stregua di Scientology, da lavaggio
del cervello, da lavanda gastrica dell’incertezza, capeggiata dal deriso
Socrate, dal quale dovrebbero scaturire alti concetti e che invece partorisce
soltanto banalità confusionarie e giri di parole per poveri allocchi. Qualche
analogia con il “Borghese
e gentiluomo” di Moliere. Sono i docenti, fancazzisti, poetastri, mariuoli,
opportunisti, cialtroni subdoli, traditori, venditori di fumo senza arrosto, predicatori,
scansafatiche, perditempo, gatto e volpe, buffoni e truffaldini, (“sempre
meglio che lavorare”, diceva qualcuno) che illumineranno lo sprovveduto
Strepsiade immerso nel suo torpore nero con fasci di luce dai palchi. In questo caso sarà l’ignorante a fare le scarpe ai dotti, proprio nel loro tempio. Già, le scarpe, grandi come pinne, instabili e grosse, gigantesche come clown, calzature da giganti non supportate da cervelli alla stessa altezza, colossi dalle caviglie d’argilla. Ma ci sono anche i bamboccioni. Non abbiamo proprio inventato nulla. Nel buio senza via d’uscita nel quale si trova strozzato dai debiti accumulati dal figlio
Fidippide, un padre (ironico, riuscito ed azzeccato Annibale Pavone) si rivolge
all’intellighenzia in voga, all’avvocatura di cavilli e azzeccagarbugli di moda
per vincere il processo ai suoi danni (vedi alla voce Taormina o Ghedini)
perfetti nel confondere le acque rimestando nel fango, per salvarsi dal dover
sborsare la cifra esorbitante. Il pensificio (potrebbe essere una delle tante, più o meno accreditate, scuole o corsi: di dizione,
scrittura creativa o management), dove si insegna a sproloquiare più che a
ragionare, “ ad imparare a combattere la giustizia”, assomiglia più ai maghi e
stregoni che affollano le televisioni private. La traduzione di Letizia Russo è,
ancora una volta, moderna e ammantata di stralci di contemporaneità,
rinvigorendo con nuova vis le parole elleniche. Il contemporaneo bussa con “Furia
cavallo del West” come di fumettistici mumble o di rustici “barcollo ma non
mollo”, di “Se stasera sono qui” operistico a cappella, di gorilla da “2001
Odissea nello spazio” avvolti nel tricolore, di “Povera patria” di Battiato, la
sigla di Canale 5. Il figlio, godereccio ed un po’
ritardato, Giamburrasca e Pierino, molto Bart Simpson, chiama il padre “babbo”
con lo stesso tono di Pinocchio, ed infatti è un pupazzo, un manichino,
piccolo, rosa, grassoccio, nudo, che come il burattino di Collodi alla fine
diviene di carne. La vita è un grande varietà dove niente è preso sul serio, un
po’ Broadway un po’ Moulin Rouge, di coriandoli e carnevalate.
Ma, fortunatamente, la morte ci coglie, ci pesca, ci
fotografa per sempre e ci raffigura così come e per quello che siamo stati:
pezzi di corpi dei quali è rimasto soltanto la fragile ossatura in un cimitero
sospeso di scheletri a mezz’aria come in una Pompei fluttuante che ci
restituisce tutta la miseria e la pietas che, in vita, abbiamo continuato a
scansare, a voler combattere pretendendo un’illusoria immortalità. Tra lifting
e denari.
Voto
8
|


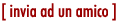 |
|





