E’ il simbolo di Firenze. Si vede
dall’alto, dalla Piana, da Fiesole. Immancabile nelle cartoline. Ha quasi
seicento anni ed ogni giorno di tutto l’anno viene
immortalata dagli scatti digitali di orde di turisti. La Cupola del Brunelleschi
che sovrasta il Duomo dona un senso di protezione a tutta Firenze, l’abbraccia, la colma, la riempie, con i suoi marmi
bianchi, le tegole rosse, la palla dorata in cima. I lavori cominciarono nel
1417 e terminarono nel 1436. Pochi anni per una cappella del diametro di
quarantadue metri che, a lavori ultimati, sfiorava le nuvole con i suoi 115 metri d’altezza. Anni
del primo Rinascimento documentati e trascritti, certificati e catalogati in
21.000 testi che finora costituivano un tesoro nascosto e inedito dell’Opera del Duomo, diretta dalla
presidentessa Anna Mitrano, e che, adesso, diventano leggibili e visionabili a
principianti e neofiti, ad addetti ai lavori ed a
studiosi, grazie alla digitalizzazione on line dei volumi, visibili
gratuitamente. Ci sono voluti più o meno gli stessi
anni (quindici) che ha richiesto la costruzione della Cupola
per approntare e preparare il sito internet
al cui interno è possibile consultare le migliaia di documenti. I lavori sono
stati condotti dalla storica dell’arte Margaret Haines
anche grazie al supporto del Max Planck Institut di Berlino
che ha permesso fattivamente la realizzazione dell’archivio digitale de “Gli anni della Cupola”.
Ne viene fuori un ritratto di Firenze a più ampio respiro, perché, in qualche
modo, quell’opera gigantesca e mastodontica riguardava tutta la città e la sua
popolazione. Dentro i documenti infatti ci sono cenni
alla vita quotidiana, così come alle feste religiose, agli usi e costumi,
all’economia, alla sicurezza sul lavoro, all’architettura. “Volevamo con
questo progetto arrivare a tre punti – spiega la professoressa Haines – la preservazione del materiale, la sua
conservazione nel tempo e la libera ed aperta fruizione
per tutti”. Brunelleschi andava a seguire i lavori della cupola tutti i
giorni. Il suo era un contratto co.co.co, nel senso
che era della durata di un anno e rinnovabile alla sua scadenza. Il suo
stipendio fino al 1425 era di 36 fiorini, come Ghiberti,
dal ’25 al ’36 invece passò a 100 fiorini l’anno. Somme ragguardevoli
all’epoca. Da questi documenti, alcuni salvati grazie al restauro
virtuale anche dall’alluvione che ne aveva sbiancato
le pagine, emerge la vita di Firenze: gli operai lavoravano dalle dieci alle
dodici ore al giorno, il pranzo se lo portavano da casa e potevano scendere
soltanto una volta al giorno. Quelli che lavoravano alla Cupola venivano pagati di più di quelli a terra ed erano
volontari, quindi un manovale non poteva essere costretto a salirci. Alcune
regole da seguire erano ad esempio il non ubriacarsi e non lanciarsi con le
funi per prendere gli uccelli da fare arrosto. Dato sconcertante, in positivo
e che ridicolizza l’attualità, è l’unico morto sul lavoro in quindici anni di
cantiere (il dimenticato Nencio di Chello) in un ambiente che non aveva certo a disposizione
caschi, ganci, scarpe protettive né la 626. L’Opera del Duomo era finanziata
ogni anno con il prelievo di una percentuale delle gabelle della Repubblica,
che corrispondeva ad una cifra tra l’1 ed il 2%
dell’intero P.I.L.
Voto
8
|
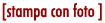
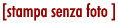
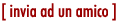 |
|





