 The Joshua Tree The Joshua Tree
 Dimmi chi erano gli U2 Dimmi chi erano gli U2
 Pop Pop
 The best of 1980-1990 The best of 1980-1990
 All that you can't leave behind All that you can't leave behind
 The best of 1990-2000 The best of 1990-2000
Profonda
provincia. Era un nevoso sabato mattina di un marzo atipico nel fatiscente
liceo scientifico che frequentavo.
C’era questo mio amico, Lorenzo, che durante la ricreazione mi si avvicinò
invitandomi a seguirlo al concerto di Vasco Rossi.
Al Palasport di Firenze.
Sessanta chilometri via autobus.
Lunedì prossimo.
Risposi: - Ci penso su. Ma la vedo dura.
A me Vasco Rossi non piaceva.
E francamente non capivo perché.
In classe piaceva a tutti, eccettuando forse Jacopo, metallaro convinto ma con un
debole per i Bon Jovi prima maniera. Vasco piaceva a ragazzi e ragazze e in
quel momento era argomento privilegiato di conversazione per l’imminente
concerto. Piaceva a Lorenzo, che prediligeva i Dire Straits, piaceva a
Cesarino, che non si sa bene cosa prediligesse, e piaceva a Luca, i cui gusti
musicali accorpavano in un’unica soluzione di continuità Clash, U2, Patsy
Kensit, e Vasco, appunto. A me no. I miei orizzonti musicali all’epoca erano in
larga parte generati della docenza scaltrita di due cugini più grandi, che
m’avevano trasmesso un buon numero di miti di riferimento, altri li avevo
trovati io: Police, Beatles, Pink Floyd, Santana, Battiato, Stones, Eurythmics,
Blues Brothers, Doors, Guccini, Bowie, Talking Heads, Hendrix e
altri ancora. Vasco non faceva parte del gruppo. Anche se non osavo manifestare
opinioni in merito perché mi dava ai nervi parlare di musica senza un background
decentemente allargato. A diciassette anni non mi sembrava d’aver sentito
abbastanza per azzardare giudizi. O almeno pensavo fosse una pessima idea.
Almeno quando un mio vecchio professore di musica m’aveva aperto spazi
sconosciuti riguardo a McCartney, di cui ignoravo qualsivoglia produzione dalla
fine dei Beatles fino a Ebony and ivory. Un piccolo buco di dodici
anni...
Comunque, la scuola finì. Io me ne tornai a casa.
Sconsolato.
Lunedì ero atteso dalla solita interrogazione-fiume di storia.
Quei maledetti undici capitoli e rotti che non ho mai imparato a programmare...
Non studiai proprio. A fine pomeriggio mi dissi che forse avrei dovuto provare.
Magari quel concerto m’avrebbe aperto un nuovo orizzonte. Sempre meglio che
sorbirmi duecento e passa pagine di guerre e successioni dinastiche. Questo è
certo. Telefonai a Lorenzo per accordarmi sulla trasferta di lunedì. Ai
biglietti pensava lui. Punto di ritrovo: a scuola, lunedì mattina, solito
orario. Per saltarla a piè pari e dirigerci a Firenze via autobus. Così fu,
tranne due trascurabili dettagli: un suo amico s’era aggregato all’ultimo
minuto, e fin qui nessun problema; in più quel giorno c’era lo sciopero degli
autobus, e questo era un grosso problema.
In quel lunedì mattina di un fine marzo curiosamente freddo grazie a tre cortesi
passaggi arrivammo fino a un minuscolo paese. In pratica uno sparuto gruppo di
case lungo la strada provinciale. C’era la neve, come cantava Guccini. E non
c’era anima viva in giro. Non passavano automobili. Un quadretto vagamente
surreale. Tra l’altro credo si trattasse dei primi autostop della mia vita. Una
situazione da schifo. Cercavo un modo per arrivare in un posto dove non ero
convinto di andare e per giunta dovevo sperare di esserci accompagnato da un
perfetto sconosciuto.
Per amore di scoperta e condivisione.
Francamente non m’aspettavo ne valesse la pena, ma qualcosa di nuovo l’avrei scoperto
comunque. Non si sarebbe trattato di Vasco Rossi. Avrei scoperto The Joshua
Tree, un disco di cui avevo sentito soltanto una canzone. With or
without you s’intitolava: quello che oggi chiameremmo singolo di lancio, ma
che nel lungo viale del tramonto del vinile era ancora il 45 giri di lancio.
Perché ancora non c’erano computer. Non
c’erano cellulari. Non c’erano sms. Non c’era Internet. E non c’era la maggior
parte delle altre amenità contemporanee.
Finì che uno dei nostri pollici direzionati verso Firenze fece breccia in
un’automobile. Forse una Fiat Uno.
Il tipo si fermò nel battistrada
Ci chiese il dove. Constatò che corrispondeva al suo. Ci offrì il sospirato
passaggio. Scese dall’auto e tolse qualcosa di grosso e rettangolare dai sedili
posteriori. Era giovane. Era un musicista. Era diretto a Firenze per esibirsi
in un locale con altri tizi di un gruppo. Nel bagagliaio aveva sistemato la sua
tastiera.
Salimmo. Il mio amico e il suo amico dietro. Io davanti accanto al tipo. Dopo la prima
decina di curve delle tante che portano fino al gelido passo della Consuma, i
miei compagni di viaggio erano già in avanzata fase R.E.M. E io mi sentivo un
po’ obbligato, per cortesia, diciamo, a conversare con il nostro salvatore.
Nel suo stereo girava un nastro. Gli altoparlanti diffondevano nell’abitacolo una
canzone. Una bella canzone. Mi suonava familiare. Ma neanche tanto. Era più un’idea
di familiarità. Un sound congeniale. Oggi quel brano lo definirei in
felice crescendo emozionale, ravvivato da un’impeccabile integrazione di basso
e chitarra. In quel momento no. Allora era solo bella musica.
Il giovane musicista mi disse che si trattava di I still haven’t found what I’m
looking for.
Dopo altre curve e le prime avvisaglie di neve e ghiaccio, capii che stavo
ascoltando The Joshua Tree all’attacco di With or without you,
una ballata calda e ombrosa che mi piaceva abbastanza. Non alla follia,
comunque. Un po’ troppo malinconica per il me stesso di allora.
Salendo ancora per la montagna arrivò una nebbia fitta come un sudario. Partì la
traccia successiva. Sprofondando nella nebulosa bianca mi arrivò il ritmo
sincopato e cupo di Bullet the blue sky. Ricordai che di questo disco,
uscito da un niente, in giro dicevano che fosse un po’ discontinuo rispetto ai
primi album degli U2. Lo dissi al pilota. Il pilota ribatté che richiedeva più
ascolti. Forse. Ma secondo lui si trattava della cosa migliore che avevano
fatto fino a quel momento. Qualcosa che sarebbe rimasto.
C’era sempre più neve per la strada. L’auto guadagnava terreno a fatica.
La nebbia ci veniva incontro a banchi sempre più ravvicinati. Entrammo
nell’ennesimo, circondati da ombre sfumate di pini a perdita d’occhio ai bordi della strada,
dietro la curva ci trovammo di fronte un cervo. Sinuoso. Tranquillo. Nonostante
la macchina si fermasse, sbandando leggermente, a meno di un metro
da lui. Immobile. Mentre nell’abitacolo era partita anche Running to
stand still. Con quell’attacco dolcissimo e rarefatto. Con quella
progressione struggente quanto insostenibile.
Con il cervo che ci guardava placidamente. Indifferente. Col fiato che gli si condensava in nuvolette irregolari. Fermo. Come se percepisse le stesse sensazioni
che ci trasmetteva la musica. Trenta secondi. Due minuti. Un’eternità. Immersa
in un silenzio assoluto. Prima di sparire all’improvviso e liberarci la via.
Intanto la canzone sfumava e subito dietro arrivava una avvolgente ballata folk rock come Red hill mining town.
E quindi In God’s country. Che non poteva che essere una ballata degli U2,
con quella tramatura chitarristica così densa e piena che avevo imparato ad amare dai
tempi di Pride.
Forse il tipo aveva ragione. Per certi versi anche torto. Quel disco mi piaceva da
impazzire. E mi arrivava subito. Mentre viaggiavamo sempre più lenti per la
neve e la nebbia, la tracklist scorreva avanti, e quell'impressione diventava una certezza.
Curva dopo curva.
E le mie orecchie impattavano con quella fantastica armonica di Trip through
your wires.
E poi con l’idilliaca malinconia di One tree hill.
E poi con quel tenebroso basso di Exit. Che si trasmutava nota dopo dopo
nota nell’epos.
Ed infine quel clangore che apriva Mothers of the disappeared. Che poi
diventava una nenia quasi liturgica.
Continuavo a rimuginare su come fosse possibile liquidare un disco così con l’aggettivo
“discontinuo”.
Mentre la cassetta arrivava alla chiave di volta e ripartiva dal primo lato scoprii
anche l’ultimo frammento.
Il frammento d’apertura. Where the streets have no
name. Che a tutt’oggi mi pare una delle cose più
straordinarie che gli U2 abbiano mai fatto. Un incipit favoloso. L’incipit
di un grande album. Il loro incipit.
Mi ritrovai a sperare che le condizioni della strada peggiorassero, per risentirmi
il disco da capo. Volevo ascoltare. Sentire ancora. Il concerto in programma per la sera era
l’ultimo dei miei pensieri.
Il mio unico compagno di viaggio sveglio sembrava condividere il mio stato
d’animo. Mi lasciava ascoltare. Ascoltava pure lui. Si limitava a suggerirmi le
sue impressioni senza essere invasivo. Quasi sempre nei pochi secondi di vuoto
che preludono all’attacco della traccia successiva. E non a caso ci scordammo
completamente di presentarci. Ignoro il suo nome, anche se, quindici anni dopo,
mi ricordo perfettamente quel viaggio. Il tipo ci lasciò nei pressi del
Palasport. Non l’ho mai rivisto.
Quel concerto di Vasco fu una pena. Era la prima volta che andavo ad un concerto al
Palasport. Ogni volta che ci sono tornato mi è sempre rifrullato in testa lo stesso
interrogativo: come è possibile che non esista in città un luogo coperto con
un’acustica migliore? L’esibizione di Vasco Rossi fu carismatica. O almeno
credo. Spesso mi ritrovavo a vagare con lo sguardo tra le facce rapite della
fauna giovanile circostante. Cercando di carpire le loro emozioni nei loro
sguardi perduti verso lo stesso punto. In mezzo a nuvole di fumo di sigarette
ed altri stupefacenti non meglio identificabili.
E continuavo a chiedermi perché mi fossi costretto ad andare là.
Non c’era feeling.
Non era il mio concerto.
Due ore e mezza più tardi mi ritrovai con gli altri due all’uscita. Ancora in
fibrillazione. Loro. M’incamminai verso casa di parenti per passare la notte. L’indomani mi
svegliai con un ciclopico mal di testa. Dopo una fugace colazione ed un ancor
più fugace saluto al parentado, ero già nei pressi della stazione degli autobus.
Due ore da smaltire in attesa del mezzo che m’avrebbe riportato a casa.
Esaurita Santa Maria Novella, gironzolai svogliatamente fino al Duomo.
Entrai anche in Santa Maria del Fiore.
All’uscita capitai davanti all’Alberti Dischi. A dieci passi di numero dal Duomo. Ora non
è più lì. Fu uno dei primi spazi commerciali del centro storico ad essere
fagocitato dall’invadenza dei negozi griffati. Che oggi si divorano anche librerie storiche come la Seeber, un'oasi libraria naturale cancellata dall'incedere del deserto modaiolo. Ma questa è un'altra storia...
Comunque, entrai dentro e, sollecitando al limite
le mie misere finanze, ne uscii con una copia di The Joshua Tree.
Altro che discontinuo.
Quel disco per me era un capolavoro.
O qualcosa di pericolosamente simile.
Aveva anche un titolo da capolavoro. Così evocativo...
L’albero di Joshua. Che nasce nel deserto. Che cresce isolato. Senza acqua. E nessuno sa perché.
Non ricordo nulla del viaggio di ritorno, ma immagino di aver parlato poco con gli
altri due ragazzi. Erano ancora estasiati per essere stati ammessi a modico
prezzo alla presenza del loro idolo. Io ero un corpo estraneo. Lo show m’aveva
lasciato indifferente. Che è il massimo della sfiga. Non potevo neanche
parlarne male. Semplicemente non m’importava. Dopo tre ore di viaggio la prima
cosa che feci a casa – l’unica, credo, a cui avevo pensato in quelle tre ore –
fu appoggiare il mio nuovo vinile sul piatto. Alzare il volume al punto giusto. Stillare per puro piacere il movimento del braccio. Abbassare la puntina. Sdraiarmi sul tappeto a luci spente e persiane socchiuse. Scivolare
nell’ascolto.
Non mi sono più perso un’uscita degli U2. Che, comunque, non sono mai diventati il mio gruppo
preferito. Una certezza, questo sì. E ho risentito anche i dischi precedenti al
1987. La chiave di volta degli U2. La metamorfosi di un gruppo irlandese di
culto nella più grande rockband del pianeta. Purtroppo. O per fortuna.
Chissà?
Col passare delle stagioni mi sono ritrovato anche a scrivere di musica. Qualche
centinaia di album finora.
Ogni tanto mi capita di recensire a ritroso anche qualche classico, come oggi
è diventato The Joshua Tree, confermando alla lettera le previsioni del
mio compagno di viaggio di tanti anni fa.
Raramente per un disco mi è capitato di ricordare con simile chiarezza di dettaglio come
e quando lo ascoltai per la prima volta.
Forse quella mattina fu anche la prima volta che scambiai impressioni articolate su
un disco con qualcuno.
Forse, chissà, la causa di quello che faccio oggi risale a quella mattina immersa in
una nebbia che si tagliava col coltello. Mi piace pensarla così.
Ero andato per condividere qualcosa. Scoprii, per caso, qualcosa di completamente
diverso.
Un gruppo che condensava impegno, musica, sogno, coesione.
Quel gruppo aveva un’anima.
E non ha mai perso la sua coerenza, la sua ragion d'essere.
Non si è mai perduto.
Per fortuna...
* Questo racconto, ricordo, bozzetto o resoconto di viaggio che dir si voglia, è
nato per caso, quando il nostro amabile direttore mi ha chiesto di recensire
“The Joshua Tree” per la sezione Cult di “Scanner”. Riascoltando il disco ho
ricordato come l’ho scoperto. Mi sono ritrovato a raccontare la mia prima volta
con gli U2 quasi senza accorgermene. Lo scritto in questione è finito al
direttore insieme alla recensione regolamentare. Abbiamo deciso di pubblicarlo,
diversamente da tutti gli altri articoli, senza inserire nessun link.
Voto
|


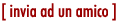 |
|





